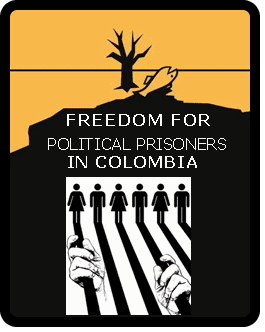Il Doing Business boccia l’integrazione latinoamericana
Secondo il recente rapporto Doing Business 2013, diffuso qualche settimana fa dal Banco Mondiale (BM) e dalla Società Finanziaria Internazionale (IFC) che ne fa parte, non sono pochi i paesi latinoamericani e dell’area caraibica che si posizionano tra le economie mondiali dove è più difficile e rischioso realizzare affari.
Il rapporto analizza una lista di 185 paesi nella quale l’Honduras si trova al 125° posto, seguito dal Brasile (130°), Ecuador (139°), Bolivia (155°), Suriname (164°), Haiti (174°) eVenezuela quasi ultimo, al 180° posto.
L’Honduras è appena preceduto dall’Argentina (124°), dal Nicaragua (119°), dalla Repubblica Dominicana (116°), da El Salvador (113°), dal Costa Rica (110°), dal Guatemala (93°).
Tra i paesi dell’America latina e centrale che vengono invece considerati positivamente dagli investitori stranieri e dove è più facile ’fare impresa’ possiamo citare senza dubbio laColombia, al 45° posto, e il Perú al 43°, addirittura uno sopra la Spagna. Il ruolo di leader della regione, da qualche anno a questa parte, invece spetta ormai al Cile, che si trova al 37° posto.
Ma su quali parametri si basa il rapporto? Il Doing Business vuole dare un quadro complessivo della qualità del business environment a livello globale e si basa sullo studio delle applicazioni delle varie normative da parte delle economie nazionali e sul loro effetto sull’incentivazione o meno degli investimenti, con un occhio di riguardo rispetto alle forme di protezione della proprietà privata. In poche parole, la classifica del Doing Business ci dice dove conviene fare affari e dove invece è meglio lasciar perdere.
Nel rapporto vengono analizzate le regolamentazioni che si applicano generalmente adieci momenti della vita imprenditoriale di un’azienda, dal suo start up alla sua liquidazione: apertura di una società, permessi di costruzione, erogazione di energia elettrica, registro delle proprietà, erogazione del credito, protezione degli investitori, carico tributario, operazioni doganali, rispetto dei contratti, risoluzione delle insolvenze.
Una visione tutta neoliberale del fare impresa che premia quei paesi dove lacci e lacciuoli statali sono ridotti all’osso e dove viene incentivato il libero gioco delle forze del mercato.La via delle nazionalizzazioni, delle riforme progressiste del lavoro, delle politiche di regolamentazione dei prezzi e dei cavilli doganali per favorire le produzioni nazionali, dell’autonomia degli Stati nazionali contro la dipendenza economica dai grandi organismi internazionali (manovrati da Wall Street) sicuramente non piacciono alla Banca Mondiale e alla Società Finanziaria Internazionale e men che meno al Fondo Monetario Internazionale.
Il Doing Business, indicando anno per anno le riforme che hanno incentivato gli investimenti e quelle invece che hanno bisogno di essere riviste, spinge i paesi alla realizzazione di norme per la liberalizzazione dei mercati, parallelamente agli aggiustamenti strutturali periodici che in quegli stessi paesi propone il FMI. Può quindi essere considerato, a tutti gli effetti, uno strumento del ’Washington Consensus’, cioè il pacchetto delle direttive economiche che secondo uno studio del 1989 dell’economista britannico John Williamson, avrebbe dovuto fissare il modello liberista dello sviluppo e che venne applicato rigidamente in America latina e centrale negli anni a venire.
Il fallimento di tale paradigma è ormai sotto gli occhi di tutti: lo ’sviluppo’ così strutturato ha portato alla concentrazione di capitali e risorse nelle mani di pochi e potenti gruppi economici, spesso stranieri, con un aumento esponenziale in tutta l’America latina nel corso degli anni ’90 e almeno fino all’inizio del nuovo secolo, dei parametri di povertà e povertà estrema, aumento che è andato di pari passo con l’aumento del debito estero contratto dai paesi di questa regione con le economie del Nord del mondo e con il FMI.
La crisi nella regione scoppiò in tutta la sua drammaticità in Argentina tra la fine degli anni ‘90 e i primi anni del duemila e provocò il collasso dell’economia del paese, dichiarato in default nel novembre del 2001. L’Argentina, con un grande sforzo, soprattutto collettivo, riuscì a risollevarsi sotto la presidenza di Néstor Kirchner, al governo nel 2003, cherinegoziò a condizioni sicuramente più vantaggiose per il paese, i pagamenti con il FMI. La ’guerra’ tra il FMI e l’Argentina continua ancora oggi, l’organismo internazionale ne ha minacciato l’espulsione proprio qualche giorno fa. E’ al governo Cristina Fernández, moglie dello scomparso Kichner, per molti aspetti più radicale del marito in politica economica.
La nazionalizzazione di settori chiavi dell’economia, come il petrolifero, un sempre maggior controllo della banche da parte del governo, il salario minimo garantito sono evidentemente tutte misure poco gradite ai centri finanziari ed economici internazionali.Ricordiamo appena qualche mese fa la crisi tra Argentina e Spagna in seguito alla nazionalizzazione della YPF a discapito della spagnola REPSOL.
Quello che tuttavia tiene in fibrillazione i centri finanziari mondiali e gli organismi che limanovrano, sono le politiche portate avanti dai governi progressisti della regione riuniti nel Mercato Comune del Sud (MERCOSUR), nell’ Alleanza Bolivariana per i Popoli della Nostra America, (ALBA) e nella recente Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi (CELAC), politiche volte ad una sempre maggiore integrazione sia economica, ma anche politica e culturale.
Osservando per esempio i paesi che fanno parte dell’ALBA (l’organismo con una più marcata impronta ideologica anti imperialista) e cioè il Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua,Dominica, Saint Vicente e Grenadine, Antigua e Barbuda, vediamo che quasi tutti, tranne Antigua e Barbuda (al 63° posto) e Saint Vicente e le Grenadine (al 75°posto) che però sono anche membri del Commonwealth delle Nazioni, si trovano in fondo alla lista delDoing Business.
Anche nel caso del Brasile, il colosso latinoamericano membro del G20 e sesta economia mondiale, la chiave di lettura del suo misero 130° posto nella classifica può essere la stessa che è stata data nel caso argentino. Il gigante giallo oro ha sempre puntato infatti più sull’integrazione regionale che sui trattati ’made in USA’.
Appare evidente anche perché il Venezuela, dalle posizioni politiche più radicali e vera spina nel fianco di Washington — che sotto la guida di Hugo Chávez dal 2001 si è incamminato sulla via del socialismo — si trovi quasi al fondo della classifica.
Il Cile e la Colombia secondo questa, sono invece i veri paradisi per gli investitori stranieri in America latina. Facile capirne le ragioni.
Il Cile rappresentò il vero laboratorio liberista nella regione fin dagli anni ’70, quando il colpo di stato ’fondomonetarista’ e la dittatura di Pinochet lasciarono campo libero aiChicago Boys (economisti cileni formatisi all’università di Chicago sotto la guidadell’ultraliberista Milton Fridman) che furono assunti dal regime militare per implementare misure economiche basate sulle privatizzazioni e sul libero mercato annullando completamente le riforme di stampo socialista che stava portando avanti il governo di Salvador Allende.
La Colombia, nonostante sia un paese martoriato da mezzo secolo di conflitto armato e nonostante sui vari governi (soprattutto quello dell’ex presidente Àlvaro Uribe) pesino come macigni le denunce di violazioni dei diritti umani, ha investito moltissimo in riforme volte ad attirare gli investitori stranieri e sulla promozione delle sue risorse naturali e del turismo. Si figura inoltre come ’punta di lancia’ dell’ imperialismo militare statunitense nella regione. Nel comunicato stampa diffuso per presentare il ’Doing Business 2013’ si legge che “la Colombia si distingue come l’economia che ha fatto di più per migliorare le regolamentazioni nel corso dello scorso anno”.
Da oltre sette anni ai vertici della classifica, come miglior paese dove poter investire denaro e dove è più facile avviare un’attività si trova Singapore, seguito a ruota da Honk Kong, dalla Nuova Zelanda e dagli Stati Uniti.
La nostra Italia si trova al 73° posto della lista, in salita di due posizioni rispetto allo studio dell’anno precedente.
*Pubblicato in esclusiva su L’Indro www.l’indro.it e qui ripubblicato per gentile concessione