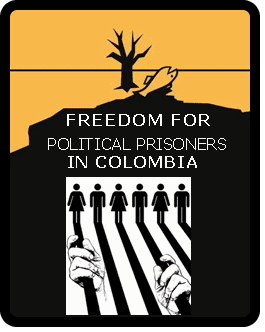Leggi il ricordo che ne fa l’amico Eliolibre nel suo blog Notizie dall’ Impero.
Guido Piccoli
traducción Simone Bruno
El pasado martes por la noche murió Sisto Turra. Un hombre brusco, irónico y cariñoso como pocos. Un anarquista que amaba provocar a la gente que le hablaba de política. Un excelente maestro para los estudiantes del Policlinico de Padua, hospital principal de esa ciudad. Mucho más que el presidente de la Sociedad Italiana de Ortopedia y Traumatología para los colegas de uniforme blanco que hoy a las 11 de la mañana, le harán un homenaje homenaje en el patio del antiguo Palacio del Bo. Pero lejos de Padua, donde vivió y murió, y de Feltre, donde nació hace 70 años y donde reposarán sus cenizas; Sisto fue principalmente “el padre de Giacomo” asesinado en Cartagena el 3 de septiembre de 1995 cuando contaba solo con 24 años. Sisto empezó a morir en este momento, cuando fue informado por un mariscal del comado de policía de Padua y, a poco después, cuando un oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Farnesina habló de sobredosis. En la narco-Colombia, Giacomo había “razonablemente” muerto por abuso de drogas. Razonable para todos, pero no para Sisto. Cuando, después de atravesar el Atlántico, le fue presentado un cadáver sobre un mármol de la morgue, quedó atónito. “Resígnese” ordenó el oficial del consulado. Pero ese no era el cuerpo de un muerto de sobredosis, sino el de un muchacho masacrado a palizas. Sisto lo gritó a todos aquellos que le aconsejaban de cargar el cuerpo en el primer avión para Italia; a los periodistas que hablaban de un italiano más “que vino a embutirse de coca y marihuana”; a la policía local, que alegó que el muchacho, bajo efectos de las drogas, se había golpeado a sí mismo, brazos, piernas, pelvis, costillas y fémur contra un poste de la luz.
Sisto en aquel entonces no entendía el motivo de tal barbarie. Al igual que Giacomo, graduado en antropología y fascinado por los indígenas de la Sierra Nevada, hacia caso omiso de la otra cara de Colombia: el terrorismo de Estado y los abusos de los hombres en uniforme que, esa noche, por casualidad, no atropellaron a sus víctimas habituales — pobre u opositores -, sino a un joven turista que se había rebelado contra unos ladrones y sus cómplices en uniforme. Sisto encontró una razón para vivir, la de hacerle justicia a su hijo. Movió montañas con el apoyo especialmente de Simonetta, Judith y Battistina, madre, hermana y tía de Giacomo; de la compañera Franca, de tantos amigos tan diferentes entre ellos como los del Centro Social Pedro de la ciudad de Padua o del oficial anti-droga Piero Innocenti de la embajada italiana en Bogotá. Empleó abogados, involucró parlamentarios y parlamentos, jueces y tribunales internacionales, logró debilitar las relaciones entre Roma y Bogotá y hacer encarcelar durante unos pocos meses a los cinco asesinos de Cartagena; hizo publicar un libro de poemas de Giacomo ( “Mi viaje”) y titularle un salón de la Universidad de Padua, estimuló la curiosidad de investigación de García Márquez, miró en la cara y le hizo bajar los ojos a Alvaro Uribe. “Tengo la sensación de no hacer algo por él, sino de hacer algo que él habría hecho” escribió un día. Empezó incluso a amar a Colombia y a los colombianos que reconoció como víctimas, de la misma manera que Giacomo, de la violencia estatal. Leyó que Giacomo se había convertido en un símbolo también en Colombia, donde la prensa había definido “Turra colombianos ” a otras personas asesinadas. Quiso creer en la seriedad del proceso, de la apelación y de la casación. Cuando se acabó la última payasada legal, Sisto empezó a morir de nuevo, rindiéndose de inmediato . Así cómo se rindió el martes, cansado de estar en una cama de hospital, atravesado por sondas y tubos, ya privado de los últimos placeres: Seneca, su whiskey, la Fórmula Uno, el coche rápido sintonizado en la emisora Marilú. Sisto Turra no podía ganar sus batallas. Pero hizo jugó su papel hasta el final. Por lo tanto se quedará en el corazón y en la memoria de quienes lo amaban. Para siempre.

SISTO TURRA, SFIDÒ BOGOTÀ IN NOME DEL FIGLIO
Guido Piccoli
Martedi notte è morto Sisto Turra. Un uomo brusco, ironico e affettuoso come pochi. Un anarchico che amava provocare chi gli parlasse di politica. Un eccellente professore per gli studenti del Policlinico. Molto più che iI presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia per i colleghi in camice bianco che oggi, alle 11, gli tributeranno l’alzabara nel cortile antico del Palazzo del Bo. Ma lontano da Padova, dov’è vissuto e morto, e da Feltre, dove nacque 70 anni fa e dove finiranno le sue ceneri, Sisto era soprattutto «il papà di Giacomo» ucciso a Cartagena il 3 settembre 1995 a soli 24 anni. Sisto cominciò a morire allora, quando fu informato da un maresciallo della questura di Padova, e poi quando un funzionario della Farnesina parlò di overdose. Nella narco-Colombia, Giacomo era «ragionevolmente» morto per droga. Ragionevolmente per tutti, ma non per Sisto. Quando, dopo il viaggio sull’Atlantico, gli fu presentato un cadavere sul marmo dell’obitorio, rimase attonito. «Si rassegni» gli ingiunse il funzionario del consolato. Ma quello non era il corpo di un morto d’overdose, bensì di un ragazzo massacrato di botte. Sisto lo urlò a tutti coloro che gli consigliavano di caricare la bara sul primo aereo per l’Italia, ai giornalisti che parlarono dell’ennesimo italiano «venuto a riempirsi di coca e marijuana», alla polizia locale che sosteneva che il ragazzo, sotto effetto della droga, si fosse fracassato da solo, contro un palo della luce, braccia, gambe, bacino, costole e femore.
Allora Sisto non capiva la ragione di tanta barbarie. Così come Giacomo, laureando in antropologia e affascinato dagli indigeni della Sierra Nevada, ignorava l’altra faccia della Colombia: il terrorismo statale e gli abusi degli uomini in uniforme che quella sera, per caso, se l’erano presa non con le solite vittime — poveri o oppositori — ma con un giovane turista che si era ribellato a alcuni ladroni e ai loro complici in divisa. Sisto trovò una ragione di vita nell’intento di rendergli giustizia. Spostò montagne col sostegno prima di tutto di Simonetta, Giuditta e Battistina, madre, sorella e zia di Giacomo, della compagna Franca, di tanti amici così diversi tra loro, da quelli del centro sociale Pedro di Padova all’ufficiale anti-droga Piero Innocenti. Ingaggiò avvocati, coinvolse parlamentari e parlamenti, giudici e tribunali internazionali, riuscì a incrinare le relazioni tra Roma e Bogotà e a far detenere per qualche mese i cinque assassini di Cartagena, fece pubblicare un libro di poesie di Giacomo («Il mio viaggio») e intitolargli un’aula dell’università di Padova, sollecitò la curiosità investigativa di Garcia Marquez, guardò in faccia e fece abbassare gli occhi a Alvaro Uribe.  «Ho la sensazione non di fare qualcosa per lui, ma di fare qualcosa che lui avrebbe fatto» scrisse un giorno. Prese perfino a amare la Colombia e i colombiani che riconobbe vittime al pari, e ancora più, di Giacomo della violenza statale. Lesse che Giacomo era diventato un simbolo anche in Colombia, dove i giornali avevano definito «Turra colombianos» altri morti ammazzati. Volle credere alla serietà del processo, dell’appello e infine della cassazione. Quando fu consumata l’ultima pagliacciata giuridica, Sisto riprese a morire, arrendendosi di colpo. Come si è arreso martedì, stanco di stare in un letto d’ospedale, infilzato da sonde e tubicini, ormai privo degli ultimi piaceri: Seneca, il suo whisky, la Formula Uno, l’auto veloce sintonizzata su radio Marilù. Sisto Turra non poteva vincere le sue battaglie. Ma ha fatto la sua parte fino in fondo. Perciò rimarrà nel cuore e nella memoria di chi l’ha amato. Per sempre.
«Ho la sensazione non di fare qualcosa per lui, ma di fare qualcosa che lui avrebbe fatto» scrisse un giorno. Prese perfino a amare la Colombia e i colombiani che riconobbe vittime al pari, e ancora più, di Giacomo della violenza statale. Lesse che Giacomo era diventato un simbolo anche in Colombia, dove i giornali avevano definito «Turra colombianos» altri morti ammazzati. Volle credere alla serietà del processo, dell’appello e infine della cassazione. Quando fu consumata l’ultima pagliacciata giuridica, Sisto riprese a morire, arrendendosi di colpo. Come si è arreso martedì, stanco di stare in un letto d’ospedale, infilzato da sonde e tubicini, ormai privo degli ultimi piaceri: Seneca, il suo whisky, la Formula Uno, l’auto veloce sintonizzata su radio Marilù. Sisto Turra non poteva vincere le sue battaglie. Ma ha fatto la sua parte fino in fondo. Perciò rimarrà nel cuore e nella memoria di chi l’ha amato. Per sempre.

Affari e Misteri sulla rotta Italia – Libia
di Antonio Mazzeo
Sono ancora tante le zone d’ombra nella storia delle relazioni politiche e militari tra Italia e Libia. Il 31 ottobre scorso, il ministro degli Esteri libico Abdurrahman Shalgam, ha ulteriormente complicato il lavoro di storici ed analisti, rivisitando gli eventi di guerra della primavera 1986, quando l’allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, diede l’ordine di bombardare Tripoli e Bengasi. La notte del 14 aprile decine di cacciabombardieri F-111 schierati in due basi britanniche e gli aerei della VI Flotta di stanza nel Mediterraneo distrussero caserme militari e abitazioni civili, causando la morte di 37 persone. Obiettivo del blitz Usa l’assassinio del colonnello Muammar Gheddafi, accusato – senza prove — di finanziare il terrorismo internazionale.
“Avvisate il colonnello!”
“Gheddafi si salvò – ha dichiarato Abdurrahman Shalgam – perché due giorni prima dell’aggressione Craxi mi mandò un amico comune italiano per dirmi: ‘Attenti, il 14 o il 15 aprile ci sarà un raid americano contro di voi’. In quell’occasione gli Stati Uniti utilizzarono la base di Lampedusa, ma contro la volontà del governo italiano, perché Roma era contraria all’uso dei cieli e dei mari nazionali per l’aggressione”.
Per il ministro libico, l’Italia faceva il doppio gioco. Nel nome dei comuni interessi (principalmente le forniture petrolifere all’Eni), l’allora presidente del consiglio Bettino Craxi avrebbe chiesto al proprio consigliere diplomatico, l’ambasciatore Antonio Badini, di preavvertire il governo libico delle intenzioni di guerra del partner Nato. Allo stesso tempo Palazzo Chigi sosteneva l’intervento “anti-terrorismo” di Washington. Un equilibrismo sul filo del rasoio. Se è pur vero, infatti, che in occasione dell’attacco Usa del 14 aprile 1986 l’Italia non autorizzò i bombardieri Usa a sorvolare lo spazio aereo nazionale, gli aerei cisterna per rifornire in volo gli F-111 partirono da una base Usa in Italia (probabilmente Sigonella), mentre tutti i porti civili e militari siciliani ospitarono le soste tecniche delle unità navali della VI flotta, alla vigilia e dopo i bombardamenti su Tripoli e Bengasi.
“Quell’attacco americano fu un’iniziativa impropria, un errore di carattere internazionale”, ha commentato Giulio Andreotti, al tempo ministro degli Esteri del governo Craxi. “E credo proprio che dall’Italia partì un avvertimento per la Libia ”, ha aggiunto il senatore a vita, confermando le “rivelazioni” libiche. Ancora più esplicita la vecchia guardia del partito socialista italiano. “Gheddafi salvato da Craxi?”, ha dichiarato Gianni De Michelis, più volte alla guida della Farnesina e ministro del lavoro nei giorni del conflitto Usa-Libia. “Si sapeva da tempo che i rapporti tra Roma e Tripoli erano più che buoni. Se c’è un filo conduttore tra la Prima e la Seconda Repubblica è senza dubbio il rapporto tra Roma e Tripoli. Da Andreotti a Craxi fino a Berlusconi, Prodi e D’Alema, si è sempre mantenuto saldo il rapporto. La Libia è quasi parte d’Italia e noi non abbiamo fatto mai mistero delle nostre idee e dei nostri contatti coi libici (…) Craxi fece avvertire il governo libico e anche gli americani subito dopo cercarono agganci, tant’è che alla fine hanno trovato una composizione anche per la strage di Lockerbee”. Anche l’allora responsabile esteri del Psi, Margherita Boniver, ha confermato l’“aiuto” di Bettino Craxi: “L’operazione militare non era condivisa e per questo il governo italiano mise in guardia Gheddafi. Ed usò tutti i mezzi a sua disposizione…”.
La rivisitazione storica di quegli eventi era già iniziata, sempre in casa dell’(ex) garofano, durante la campagna di beatificazione del defunto leader socialista. “Fu Craxi a informare Gheddafi dell’imminente blitz americano, permettendo al leader libico di salvarsi”, rivelò nel 2003 Cesare Marini, senatore Sdi. Non è stato dunque uno scoop quello di Abdurrahman Shalgam. Del doppio canale diplomatico si sapeva da tempo.
Giochi di guerra nel Mediterraneo
Ecco perché le dichiarazioni dell’alto rappresentante dell’esecutivo libico hanno prodotto forti perplessità e qualche risentimento tra alcuni dei protagonisti politici che nel biennio 1985–86 si opposero alla campagna di guerra nel Mediterraneo, denunciando altresì l’asfissiante processo di militarizzazione della Sicilia che ne derivò. Gli esponenti dell’allora forte movimento pacifista siciliano ricordano che l’Italia era in prima linea contro la Libia a fianco di Washington e che proprio Bettino Craxi e l’intero partito socialista erano tra i più accesi denigratori dei pacifisti, accusati tutti di essere manovrati e finanziati da Gheddafi. L’on. Agostino Spataro, ex componente Pci delle Commissioni Affari esteri e Difesa della Camera dei Deputati, ricorda su Aprile che nonostante l’“avviso”, sotto le bombe statunitensi morì la figlioletta adottiva di tre anni del colonnello libico. “In realtà – spiega l’ex parlamentare — quella notte è accaduto quello che da tempo si temeva, e si sapeva, ovvero che l’amministrazione Reagan aveva già pianificato l’attacco alla Libia”.
Spataro aggiunge che a seguito dell’attacco, il 15 aprile 1986, la Libia rispose con il lancio di due missili Scud contro la stazione Loran dell’Us Guard Coast ospitata nell’isola di Lampedusa. “Gheddafi, infuriato per la vile, indiscriminata aggressione, non indirizzò la rappresaglia verso uno dei tanti possibili obiettivi Usa, ma scagliò i suoi missili contro l’Italia ovvero contro il paese-amico il cui capo del governo l’aveva avvisato dell’imminente pericolo. Ma quei due missili partirono dal suolo libico e soprattutto raggiunsero effettivamente Lampedusa? Già allora affiorarono seri dubbi, sia per la scarsa potenzialità ed efficienza della tecnologia militare libica e sia per fatto, non secondario, che i lampedusani non si accorsero dell’arrivo dei due potenti ordigni. Ancora oggi si sconosce il punto esatto dell’impatto. Nessuno è in grado di dimostrare che i due missili siano arrivati a Lampedusa e o nelle sue immediate vicinanze”.
Per il socialista Cesare Marini si trattò di mera “finzione”: il lancio dei missili su Lampedusa fu solo un espediente depistante, “utilizzato per coprire l’amico italiano” d’avanti agli Stati Uniti. “Di certo io non mi sono spaventato”, ha dichiarato l’immancabile Giulio Andreotti. “La mia sensazione è che i missili furono lanciati ma volutamente fuori bersaglio: non c’era nessuna volontà di causarci dei danni”. Una vera e propria fiction di guerra, dunque.
Il pomeriggio del 15 aprile 1986, gli abitanti di Lampedusa avvertirono due boati a largo dell’isola. Il primo dispaccio di agenzia parlò di “cannonate sparate da una motovedetta libica”. Qualche minuto dopo si parlò del “Bang” dovuto al passaggio a bassa quota di aerei supersonici. Intorno alle 18 le autorità americane informarono il ministro della Difesa italiano, Giovanni Spadolini, del lancio di due missili contro l’isola. Gli ordigni però erano caduti a un paio di chilometri dalla costa. Il giorno successivo l’ambasciatore libico a Roma confermò l’attacco: “I missili sono venuti dalla Libia. Ma non abbiamo cercato di colpire l’Italia ma una base Usa”.
Due missili che si sono persi nel nulla
Ma che accadde realmente quel giorno? A rendere più torbidi i contorni della vicenda ci ha pensato l’ex generale, Basilio Cottone, siciliano originario del comune di Raccuia (Messina), capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare dal 1983 al 1986. In un’intervista al quotidiano Pagine di Difesa del 20 settembre 2005, Cottone, si è detto scettico del lancio dei missili libici. “Sono stato responsabile dell’approntamento della reazione italiana al lancio dei missili su Lampedusa”, ha esordito l’ex militare. “Personalmente non ho mai creduto che siano stati lanciati missili da parte libica contro il territorio italiano. Ma, poiché allora tutti lo credevano, ho ritenuto di operare di conserva. La notizia del lancio dei missili per me era falsa e le azioni messe in atto volevano accreditarla. Molte organizzazioni extranazionali erano allora interessate al fatto che il governo italiano adottasse una politica di più forte chiusura nei confronti della Libia. È da tener presente che negli anni ‘70 e gli inizi degli ’80, gli attentati terroristici contro obiettivi occidentali erano numerosi. Tra questi: dirottamenti di aerei passeggeri, abbattimenti di velivoli commerciali, strage alla Olimpiade di Monaco del ‘72 e attentato di Fiumicino della fine del ‘73. In questo quadro si inserisce la missione in Libia di Argo-16 con la quale sono stati fatti rientrare i terroristi palestinesi arrestati a Fiumicino mentre preparavano un attentato a un velivolo di linea israeliano. Questi, e altri eventi successivi, portarono a un irrigidimento politico da parte degli occidentali verso la Libia di Gheddafi”. Basilio Cottone sostiene che “qualcuno” tentò di creare le condizioni per incrinare irrimediabilmente le relazioni Roma-Tripoli. “Da qui alle notizie dei missili su Lampedusa la strada fu breve. Penso, sia stata un’azione di ‘servizi’ che hanno montato la cosa, però il fatto ha assunto credibilità internazionale ed è rimasto nell’immaginario collettivo il lancio concreto”.
Alle parole dell’ex capo di stato maggiore, hanno fatto seguito quelle del generale Mario Arpino, successore di Cottone alla guida dell’Aeronautica. In un’intervista a L’Espresso (25 novembre 2005), Arpino ha ammesso che le forze armate non raccolsero mai nessuna prova evidente dell’attacco missilistico. “I nostri radar non erano in grado di scoprire missili di quel genere”, ha aggiunto il generale. “Avevamo chiesto alla Nato di fornirci degli Awacs, radar volanti molto potenti, ma ci furono concessi mesi dopo. Io ero responsabile della sala di crisi e gli americani non mi comunicarono nulla. Se informavano qualcuno, lo facevano a livello politico. So con certezza che non venimmo nemmeno avvisati del raid contro Tripoli. Ricordo la sorpresa quella notte quando i nostri radar scoprirono gli aerei diretti in Libia”.
Prima della nomina ai massimi vertici dell’AMI, Basilio Cottone era stato comandante della 5° Ataf di Vicenza, la forza aerotattica della Nato, e successivamente rappresentante militare italiano presso il Comitato dell’Alleanza Atlantica di Bruxelles. Dimessosi dalle Forze Armate, l’alto ufficiale fu nominato, il 14 aprile 1993, presidente del consiglio d’amministrazione dell’Agusta Spa, società leader nella produzione di elicotteri da guerra. Ai vertici dell’industria di elicotteri, Cottone ci resterà ininterrottamente per sette anni, per poi divenirne consigliere. L’ingresso del generale in Agusta avvenne quattordici giorni prima della caduta del primo governo di Giuliano Amato (Psi), ministro della difesa il siciliano Salvo Andò (Psi) e sottosegretari due potenti politici della provincia di Messina, Salvatore D’Alia (Dc) e Dino Madaudo (Psdi). La nomina del generale Cottone fu adottata dall’allora commissario liquidatore dell’Efim, Alberto Predieri, dopo l’arresto del manager Roberto D’Alessandro, ex presidente Agusta — poi prosciolto — nell’ambito dell’inchiesta sul pagamento di tangenti a favore del Partito socialista per la fornitura di 12 elicotteri alla Protezione civile (ministro, allora, Nicola Capria, Psi e anch’egli messinese).
L’1 settembre 1993, un’altra inchiesta, “Arzente Isola”, avrebbe coinvolto l’Agusta relativamente ad una transazione di armi gestita da alcuni faccendieri messinesi sulle rotte Italia-Antille Olandesi-Perù-Siria. Nello specifico, nella primavera del 1992 fu avviata la trattativa per il trasferimento di dodici elicotteri CH47 “Agusta” alla Guardia nazionale dell’Arabia Saudita. Tra gli intermediari dell’affaire, il noto trafficante d’armi arabo Adnan Kashoggi ed imprenditori vicini all’entourage dell’odierno presidente del consiglio italiano. Alla fine, però, l’inchiesta giudiziaria si arenò nelle sabbie mobili della Procura di Messina.
Armi e cemento per i partner nordafricani
L’Agusta, oggi AgustaWestland, è con l’Eni una delle prime società italiane tornate ad operare in Libia dopo il riavvicinamento Roma-Tripoli. Nel gennaio del 2006 sono stati forniti alle forze armate libiche, 10 elicotteri A109 Power, valore 80 milioni di euro, destinati al “controllo delle frontiere”. La società italiana ha pure sottoscritto un accordo con la Libyan Company for Aviation Industry per costituire una joint venture ( la Libyan Italian Advanced Tecnology Company — Liatec), per lo sviluppo di attività nel settore aeronautico e dei sistemi di sicurezza. L’anno successivo è stata la volta di Finmeccanica, la holding che detiene il controllo di AgustaWestland, a firmare un accordo con il governo libico per la creazione di una joint venture nel campo dell’elettronica e dei sistemi di telecomunicazione per la difesa, con target il mercato libico e parte del continente africano. Nel gennaio 2008, Alenia Aeronautica, altra società del gruppo Finmeccanica, ha siglato con il ministero dell’Interno libico un contratto del valore di oltre 31 milioni di euro per la fornitura del velivolo da pattugliamento marittimo ATR-42MP “Surveyor”.
L’industria bellica italiana attende trepidante la ratifica del Trattato di cooperazione italo-libico sottoscritto da Silvio Berlusconi e dal colonnello Gheddafi. All’articolo 20 del Trattato si prevede infatti “un forte ed ampio partenariato industriale nel settore della Difesa e delle industrie militari”, nonché lo sviluppo della “collaborazione nel settore della Difesa tra le rispettive Forze Armate”, mediante lo scambio di missioni di esperti e l’espletamento di manovre congiunte (anche se è dal 2001 che le marine militari di Italia e Libia effettuano annualmente l’esercitazione “Nauras” nel Canale di Sicilia). I due paesi s’impegnano altresì a definire “iniziative, sia bilaterali, sia in ambito regionale, per prevenire il fenomeno dell’immigrazione clandestina nei Paesi di origine dei flussi migratori”.
Non è stata certo una coincidenza che le dichiarazioni del ministro Shalgam sul pre-avvertimento del bombardamento Usa nel 1986 siano coincise con il convegno organizzato a Roma dalla fondazione guidata dall’ex ministro Beppe Pisanu, presenti Giulio Andreotti, il ministro degli Esteri Franco Frattini, il figlio primogenito del leader libico, Saif El-Islam, e il gotha dell’imprenditoria italiana (Eni, Enel, Telecom, Unicredit, Trenitalia, Bnl, Fondiaria-Sai, Impregilo, ecc.). In cantiere ci sono opere “compensatorie” dei crimini coloniali italiani per 5 miliardi di dollari da realizzare in Libia nei prossimi 20 anni. Il Trattato di cooperazione Italo-libico prevede espressamente che saranno le aziende italiane a realizzare i progetti infrastrutturali.
Intanto il capitale libico fa incetta di pacchetti azionari delle maggiori società italiane. Acquisito il 4,9% di Unicredit, la Central Bank of Libya starebbe per rilevare una quota tra l’1 e il 2% di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale. I libici starebbero pure per fare ingresso in Impregilo, il colosso delle costruzioni italiane, general contractor per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, del Mose di Venezia e di importanti tratte della TAV ferroviaria. I libici punterebbero ad acquistare circa il 5% del capitale, ottenendo pure un posto nel consiglio d’amministrazione d’Impregilo. In Libia, del resto, il gruppo italiano ha costituito qualche mese fa una joint venture per realizzare tre università nelle città di Misuratah, Tarhunah e Zliten (valore del contratto, 400 milioni di euro).
Al convegno di Roma del 31 ottobre, l’amministratore delegato d’Impregilo, Massimo Ponzellini, è comparso accanto a Saif El-Islam. Cresciuto all’ombra dell’ex presidente del consiglio Romano Prodi, dopo aver ricoperto l’incarico di direttore generale del centro studi Nomisma e dirigente superiore dell’IRI, Massimo Ponzellini passò a sedere nel consiglio d’amministrazione di Finmeccanica. Amministratore delegato della holding di controllo del complesso militare industriale italiano è stato pure Alberto Lina, amministratore delegato d’Impregilo sino al 2007.
Armi e cemento segnano la strategia di penetrazione in nord Africa del capitale finanziario nostrano. “Italiani? Brava gente…”.

è anche bello… per analisi più approfondite rimando al sito dell’amico Gennaro Carotenuto, che io non ho proprio tempo… Salutiamo comunque con qualche speranza l’elezione di Barak Obama e come Oliver Stone dico: Caro Mr. Bush, che sollievo, lei non sarà più presidente!
Leggi anche su AgoraVox.

Ascolta qui la registrazione della trasmissione
Domani, mercoledì 5 novembre, ore 11, RADIO ONDA ROSSA percorrerà gli eventi della prima guerra mondiale:
La sofferenza umana, i profitti del padronato, l’inettitudine degli alti comandi, le speculazioni in borsa di Cadorna, le trincee e i reticolati, la vanghetta del fante, la feroce disciplina militare, i manicomi, la prigionia, le fucilazioni, la narrativa e la propaganda per bambini, l’incetta dei prodotti agricoli, gli operai sorvegliati dai carabinieri, la La fame e la miseria, la guerra nelle lettere e nei diari dei soldati.…
680.000 morti,
1.050.000 feriti,
500.000 mutilati,
25.000 ricoverati in manicomio,
26.000 tubercolotici…
Poi hanno smesso di contare…
…
conduce Salvatore Ricciardi, partecipa Gavino Puggioni

Guai in vista per John McCain. La notizia potrebbe rappresentare il colpo di grazia per la corsa alla Casa Bianca del senatore repubblicano, giunta ormai alle battute finali.
Il “siluro” per McCain è partito oggi dal quotidiano uruguaiano la República, con la pubblicazione in prima pagina dell’articolo a firma di Roger Rodriguez , il giornalista che sta seguendo questo caso fin dal 2002, ed è stata già passata alle agenzie statunitensi.
Frederick W. Latrash, consigliere e segretario personale di Mc Cain, nonché ex capo della CIA in Uruguay nel 1976, sarebbe coinvolto direttamente nell’omicidio dell’ex presidente brasiliano di sinistra, Joao Goulart morto in quello stesso anno, nel mese di dicembre.
La denuncia è stata fatta da uno dei figli di Goulart, che accusa Latrash di essere stato colui che ha portato direttamente in Argentina, dove l’ex presidente si trovava in esilio dopo la destituzione a causa del colpo di stato del 1964 appoggiato dagli Stati Uniti, le pasticche avvelenate a base di cloruro di potassio o di sodio, preparate in Uruguay dal dottor Carlos Milies (alias capitano Adonis) e che agenti dei servizi segreti avrebbero scambiato nella residenza di Goulart con le medicine che lui prendeva abitualmente.
La decisione di uccidere l’ex presidente brasiliano sarebbe stata maturata nel corso di una riunione segreta avvenuta nel mese di novembre 1976 a Montevideo e alla quale oltre a Latrash parteciparono Sergio Paranhos Fleury , un ufficiale di polizia brasiliano noto torturatore sanguinario dei giovani sacerdoti della Teologia della Liberazione (tra i quali Frei Tito, che incapace di dimenticare le torture subite da Paranhos si suiciderà in Francia nel 1974) e il colonnello uruguayano Luis V. Queirolo
Questo dettaglio della riunione del novembre 1976 è stato confermato nel corso del suo interrogatorio svoltosi a Montevideo nel maggio di quest’anno, da Mario Ronald Barreiro Neira, ex agente dei servizi segreti uruguaiani, che già nel 2002 aveva rivelato al giornalista de la República , Roger Rodriguez, che l’ex presidente brasiliano non sarebbe morto per un arresto cardiaco come si era creduto fino a quel momento, ma era stato ucciso da un potente veleno. L’uomo si trova attualmente in un carcere di massima sicurezza in Brasile scontando una pena per traffico di armi e rapina in banca.
L’omicidio dell’ex presidente brasiliano, sarebbe pertanto avvenuto nell’ambito del plan Condor, dal momento che oltre agli Stati Uniti hanno partecipato alla sua realizzazione anche il Brasile e l’Uruguay.
E’ stata avanzata la richiesta intanto, allo Stato brasiliano, da parte di associazioni per la difesa dei diritti umani, da una commissione parlamentare e dalla magistratura di Río Grande do Sul, di riaprire gli archivi relativi alla dittatura brasiliana e la desecretazione di documenti agli Stati Uniti.

Sono gravissime le ultime dichiarazioni di Francesco Cossiga. Ma credo che sia ancor più grave banalizzare o fare della semplice ironia su di esse o sulla sanità mentale di chi le ha rilasciate. Grave e pericoloso. Giorgiana Masi è morta proprio applicando la “dottrina Cossiga”, un giorno di maggio del 1977. Aveva 19 anni. La stessa età dei ragazzi che in questi giorni stanno riempiendo le strade e le piazze di tutta Italia.
Uccisa per mano di un poliziotto infiltrato in una manifestazione organizzata dal Partito Radicale.
A 31 anni di distanza da quel tragico giorno non si conosce ancora il nome dell’assassino. Noi non lo conosciamo. Francesco Cossiga, presidente emerito della Repubblica Italiana, che all’epoca era Ministro dell’Interno, invece sa benissimo come sono andati i fatti e chi sono i responsabili, come ha ammeso lui stesso in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. Niente di strano, dal momento che è stato lui il mandante confesso di quell’omicidio di Stato: “Maroni dovrebbe fare quel che feci io quando ero Ministro dell’Interno (…) Infiltrare il movimento con agenti pronti a tutto…”
La chiamano la “strategia Cossiga” e trovo che sia un termine troppo tenero per indicare quello che in altri paesi viene generalmente chiamato con il nome di terrorismo di Stato. Spaventa il timore che si ha a chiamare le cose con il proprio nome, anche da parte di chi scende oggi in piazza e quindi al momento potrebbe essere la prossima vittima di un qualsiasi “agente pronto a tutto”.
Si ha paura di parlare o forse la potenza del linguaggio si è sopita insieme alla coscienza politica del nostro paese. Ci avviciniamo ad altre realtà, per esempio quella latinoamericana, senza timori, senza reticenze, non abbiamo remore nel chiamare un presidente paraterrorista o nel denunciare e fare appelli contro l’impunità di cui godono alcune istituzioni e le forze dell’ordine chiamate a rappresentarle.
Raccogliamo firme e manifestiamo contro i crimini di stato che avvengono a migliaia di chilometri di distanza dal nostro paese. Il linguaggio scritto e parlato, invece, per qualche misteriosa inibizione, assume tutt’altro tono quando i crimini di stato avvengono a casa nostra.
La dichiarazione di Cossiga altro non è che la confessione di un omicidio.
Ha fatto scalpore nei giorni scorsi il presidente colombiano quando ha confessato pubblicamente, (costretto dall’ evidenza delle immagini di un video della BBC) che la polizia ha sparato ad altezza d’uomo sui manifestanti indigeni nel corso della marcia di protesta della scorsa settimana. Noi le immagini di poliziotti in borghese con le armi in pugno ad altezza d’uomo le guardiamo da trentuno anni, da trentuno anni il nostro paese sa che da una strategia di Stato o di Cossiga che dir si voglia, è partito il colpo che ha ucciso Giorgiana Masi e ferito gravemente altre due persone.
A distanza di trentuno anni, il mandante, l’autore intellettuale di quell’omicidio, confessa pubblicamente sulle pagine di un quotidiano che quella è stata una strategia studiata a tavolino e una tale dichiarazione provoca reazioni da operetta.
Lo stesso presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al quale è stato rivolto un laconico appello a prendere posizione, tace. E il silenzio, insegnano alcuni, spesso è sintomo di complicità.
Per ora pistole in giro non se ne sono viste, ma armi improprie sì e in abbondanza. A Piazza Navona, nel corso degli scontri di due giorni fa c’erano in mano agli “studenti” del Blocco Studentesco bastoni avvolti dal tricolore, moschettoni, cinture con fibbie di metallo, caschi e quant’altro.
 E domandandosi come sia possibile che un camion carico di tale armamentario sia potuto arrivare fino a Piazza Navona, in una piazza assediata da forze dell’ordine in assetto antisommossa, non possiamo non domandarci anche chi fossero quegli strani personaggi che nei filmati che stanno circolando in rete in questi giorni si vedono parlottare con le forze dell’ordine.
E domandandosi come sia possibile che un camion carico di tale armamentario sia potuto arrivare fino a Piazza Navona, in una piazza assediata da forze dell’ordine in assetto antisommossa, non possiamo non domandarci anche chi fossero quegli strani personaggi che nei filmati che stanno circolando in rete in questi giorni si vedono parlottare con le forze dell’ordine.
Come inquietanti appaiono gli spezzoni dei dialoghi tra i poliziotti, frasi raccolte e testimoniate da Curzio Maltese: “arrivano quei pezzi di merda dei comunisti!”, “allora si va in piazza a proteggere i nostri? Sì ma non subito”…
Perchè non si indaga su questi episodi? Perchè non si procede come si dovrebbe penalmente contro le dichiarazioni pubbliche di Francesco Cossiga che in un momento come questo non sono altro la rivendicazione che un terrorista fa di un suo attentato?
Da alcuni parlamentari Radicali-PD( Donatella Poretti Maurizio Turco) è stato presentato in questi giorni un disegno di legge per l’istituzione di una Commissione Parlamentare di Inchiesta sull’omicidio di Giorgiana Masi. La proposta è stata accolta e sostenuta anche dai senatori Marco Perduca, Felice Casson e Gianrico Carofiglio. Alfio Nicotra invece, responsabile del dipartimento Pace e Movimenti del Prc, portavoce del Genoa Social Forum durante il G8 di Genova 2001, considera le parole di Cossiga una vera e propria confessione di colpevolezza.
Da quanti anni il paese chiede una commissione di inchiesta sull’omicidio di Giorgiana Masi? Da quanto tempo il paese sa e tollera che il mandante di quell’omicidio si prenda sberlefffo della memoria di una ragazza di diciannove anni? Quanto ancora dobbiamo aspettare perchè il paese venga scosso da questo torpore nel quale pericolosamente è caduto?
Duccio, uno studente di Filosofia che era a Piazza Navona due giorni fa, ha detto ad un giornalista: “E’ il metodo Cossiga. Ci stanno fottendo”. Non è così, cari ragazzi, ci hanno già fottuto tanti anni fa. E hanno continuato a farlo fino ad ora. E noi glielo abbiamo lasciato fare.

Stamattina ci sono stati scontri a Roma, a Piazza Navona e in prossimità del Senato tra studenti antifascisti e studenti del Blocco Studentesco (di destra) che hanno attaccato la testa del corteo.La polizia è intervenuta solo dopo che gli studenti antifascisti sono stati picchiati con bastoni e moschettoni.
Gli studenti stanno tornando in questo momento alla Sapienza dove avrà luogo un’assemblea e una conferenza stampa sull’accaduto.
Da Radio Onda Rossa nelle prossime ore la diretta della conferenza stampa e tutti gli aggiornamenti della situazione anche da altre città.
Intanto il decreto Gelmini è stato firmato.

 «Ho la sensazione non di fare qualcosa per lui, ma di fare qualcosa che lui avrebbe fatto» scrisse un giorno. Prese perfino a amare la Colombia e i colombiani che riconobbe vittime al pari, e ancora più, di Giacomo della violenza statale. Lesse che Giacomo era diventato un simbolo anche in Colombia, dove i giornali avevano definito «Turra colombianos» altri morti ammazzati. Volle credere alla serietà del processo, dell’appello e infine della cassazione. Quando fu consumata l’ultima pagliacciata giuridica, Sisto riprese a morire, arrendendosi di colpo. Come si è arreso martedì, stanco di stare in un letto d’ospedale, infilzato da sonde e tubicini, ormai privo degli ultimi piaceri: Seneca, il suo whisky, la Formula Uno, l’auto veloce sintonizzata su radio Marilù. Sisto Turra non poteva vincere le sue battaglie. Ma ha fatto la sua parte fino in fondo. Perciò rimarrà nel cuore e nella memoria di chi l’ha amato. Per sempre.
«Ho la sensazione non di fare qualcosa per lui, ma di fare qualcosa che lui avrebbe fatto» scrisse un giorno. Prese perfino a amare la Colombia e i colombiani che riconobbe vittime al pari, e ancora più, di Giacomo della violenza statale. Lesse che Giacomo era diventato un simbolo anche in Colombia, dove i giornali avevano definito «Turra colombianos» altri morti ammazzati. Volle credere alla serietà del processo, dell’appello e infine della cassazione. Quando fu consumata l’ultima pagliacciata giuridica, Sisto riprese a morire, arrendendosi di colpo. Come si è arreso martedì, stanco di stare in un letto d’ospedale, infilzato da sonde e tubicini, ormai privo degli ultimi piaceri: Seneca, il suo whisky, la Formula Uno, l’auto veloce sintonizzata su radio Marilù. Sisto Turra non poteva vincere le sue battaglie. Ma ha fatto la sua parte fino in fondo. Perciò rimarrà nel cuore e nella memoria di chi l’ha amato. Per sempre.



 E domandandosi come sia possibile che un camion carico di tale armamentario sia potuto arrivare fino a Piazza Navona, in una piazza assediata da forze dell’ordine in assetto antisommossa, non possiamo non domandarci anche chi fossero quegli strani personaggi che nei filmati che stanno circolando in rete in questi giorni si vedono parlottare con le forze dell’ordine.
E domandandosi come sia possibile che un camion carico di tale armamentario sia potuto arrivare fino a Piazza Navona, in una piazza assediata da forze dell’ordine in assetto antisommossa, non possiamo non domandarci anche chi fossero quegli strani personaggi che nei filmati che stanno circolando in rete in questi giorni si vedono parlottare con le forze dell’ordine.